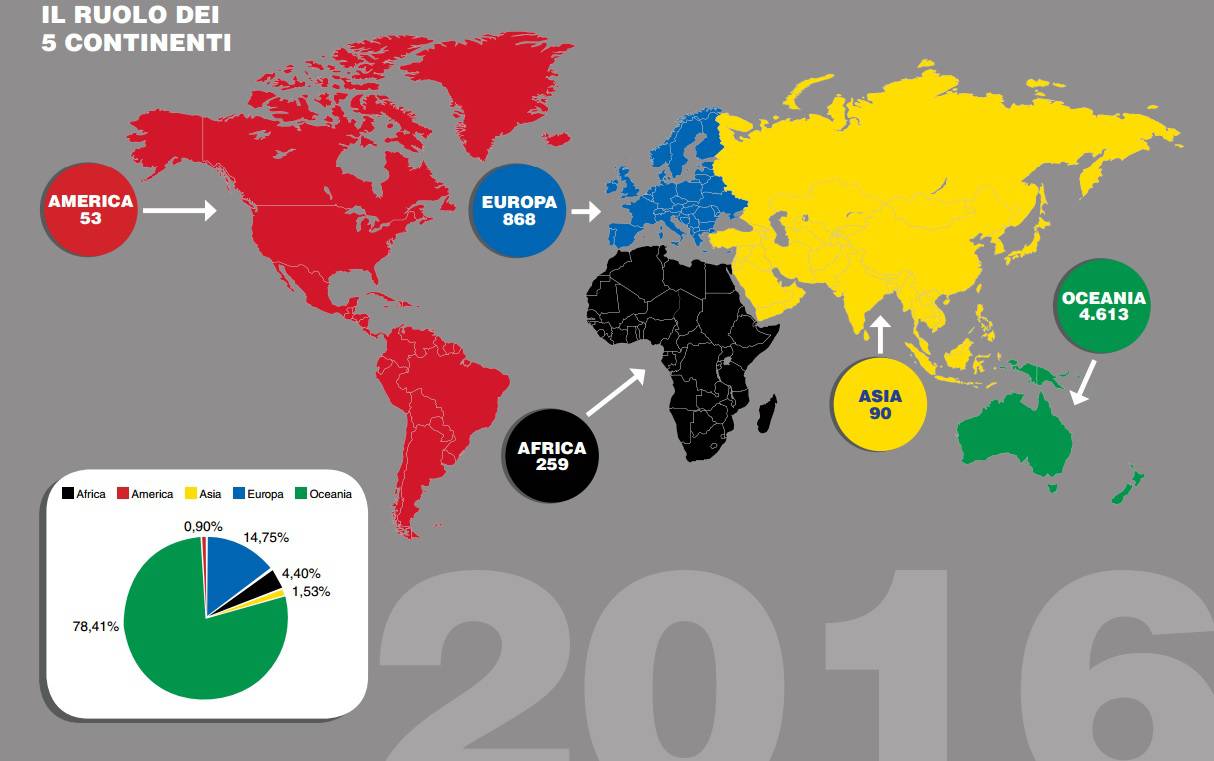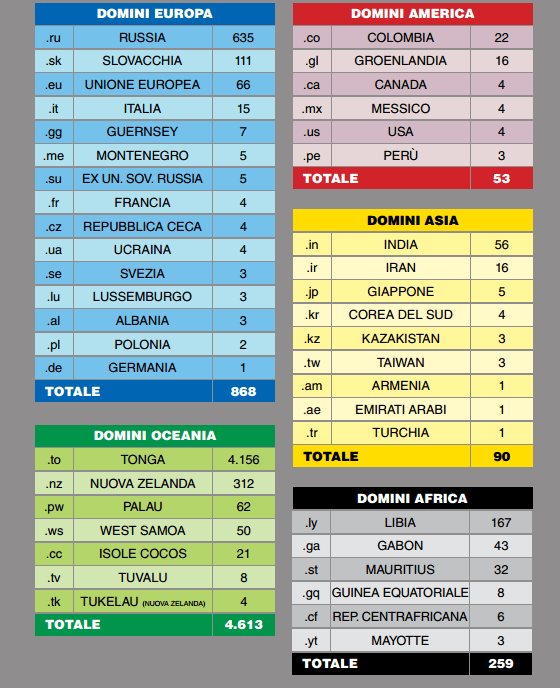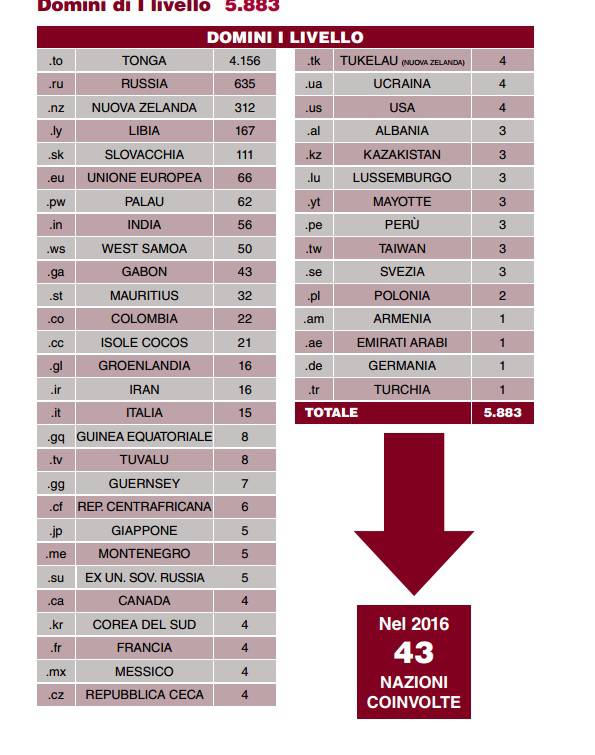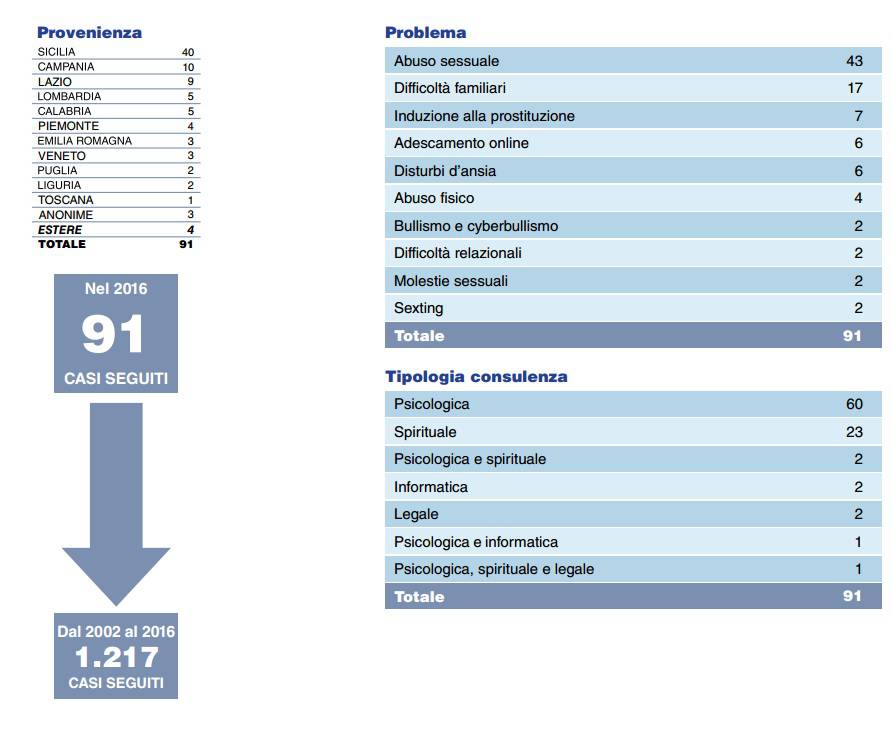Prima del 1992, lo Stato controllava il 73% di quella che potremmo chiamare l’industria del credito. Quindi l’operazione di privatizzazione è stata imponente e ha rappresentato un’autentica rivoluzione in nome di una marcata ortodossia liberista.
In circa 10 anni, sono state privatizzate aziende statali per un valore di oltre 220.000 miliardi di lire. Di fatto, è stato liquidato l’IRI, e sono state vendute grandi società pubbliche quali Telecom, ENEL, ENI (quest’ultime 2 solo in parte), e praticamente tutte le banche precedentemente controllate dallo Stato. Su queste ultime concentreremo la nostra analisi.
Esiste un vero esecutore del grande processo di privatizzazione: Mario Draghi, oggi direttore della BCE. Draghi, insieme agli altri economisti come Prodi, non attesero nemmeno una legislazione sulle liberalizzazioni. Legislazione che avrebbe potuto impedire un passaggio da monopoli pubblici a monopoli privati. Due avvenimenti condizionarono questa scelta operativa: il primo era il trattato di Maastricht firmato nel ’92; il secondo, il grande scandalo di Tangentopoli.
Quest’ultimo sembrò delegittimare il parlamento, non ritenendolo in grado di legiferare su questioni di cui non si potevano accettare ritardi intollerabili che avrebbero rallentato un processo verso il liberismo, verso l’euro e la BCE, quelle istituzioni liberiste che erano già previste nel trattato di Maastricht appunto.
Possiamo subito aggiungere che anche chi partecipò alla “struttura” di Draghi ha ammesso recentemente che quella scadenza fu usata come una sorta di leva per ridisegnare e ridurre il ruolo dello Stato, la presenza dello Stato nell’economia italiana.
Paradossalmente i dati non sono sempre omogenei, anche se si tratta di vendita di beni dello Stato, quindi di tutti i cittadini italiani. Ad esempio, il vecchio Credito Italiano, oggi Unicredit, fu venduto per 1830 miliardi di lire, corrispondenti a una capitalizzazione della banca di 2700 miliardi di lire, mentre il valore della banca in base della quotazione di Borsa il giorno di fissazione del prezzo era di 3012 miliardi. Il fatto è che, appena dopo sei anni di privatizzazione, Unicredit capitalizzava già 26593 milioni di euro. Poi nel 2007, dopo la fusione con Capitalia, valeva 100 miliardi di euro e oggi ne vale appena 20,15 (dopo un aumento di capitale da 7 miliardi).
Per quanto riguarda la Banca Commerciale Italiana, la banca di Raffaele Mattioli, che aveva il più grande “know-how” nel credito per l’impresa, fu ceduta per 2891 miliardi di lire che divennero 3005 per via del dividendo del 1993. La Banca di Roma venduta per 977 milioni di euro, capitalizzava 4.087 milioni di euro. Il caso del Banco di Napoli ha addirittura dell’incredibile! Il 60% che lo Stato vendette alla Bnl per 32 milioni di euro (dopo averlo ripulito di crediti inesigibili e di perdite per 6.200 milioni di euro) è stato rivenduto dopo pochi anni da Bnl per mille milioni di euro.
Sentiamo cosa disse il Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi: “Il Tesoro vuole valorizzare prima di vendere. È un suo dovere nei confronti dei cittadini, che dopo aver profuso risorse per risanare i conti delle imprese pubbliche non tollererebbero regali al momento della loro vendita”, ha fatto proprio un bel lavoro…
E le transazioni dovute alla privatizzazione a chi sono state commissionate? A banche anglosassoni! Questi commissionamenti per i collocamenti in Borsa ci sono costati tra il 2-3% dell’ammontare del ricavato. Circa l’1% sull’ammontare totale (2.200 miliardi di lire), è andato diritto nelle già ampie tasche delle banche d’affari anglosassoni (JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, First Boston, Merril Lynch e via cantando)per la loro attività di consulenza.
Nei primi anni Duemila, la moda prevalente nel sistema bancario internazionale fu quella della corsa alla crescita dimensionale attraverso fusioni e acquisizioni. Anche il sistema bancario italiano si concentrò molto. Troppo: nel senso che si creò un oligopolio di poche grandi banche. Furono così privatizzate tutte le grandi banche commerciali, tutte le banche a medio-lungo termine (che facevano credito per gli investimenti delle imprese), e addirittura banche di sviluppo come il Mediocredito centrale abbiamo cambiato i princìpi guida dell’attività bancaria: prevalse il criterio del profitto di breve termine e della «creazione di valore per gli azionisti», a sua volta identificata con l’andamento in Borsa del titolo. La gestione delle banche cominciò a seguire tutte le «mode» che favorivano la crescita in Borsa del titolo relativo. Inclusi la speculazione finanziaria sempre più spinta, l’uso di società veicolo fuori bilancio per aumentare la leva finanziaria (ossia per fare più operazioni con sempre meno capitale proprio) e l’utilizzo di prodotti finanziari derivati.
Ricordo anche che dal 1987 al 2000 il numero delle banche è sceso da 1200 a 864 e, soprattutto, alla faccia della concorrenza, della liberalizzazione e delle public company si sono costituiti, verso la fine degli anni Novanta, cinque gruppi che, da soli, controllano quasi il 50% del mercato del credito: Unicredit, Intesa Bci, San Paolo Imi, Banca di Roma e Montepaschi. Si pensi che, prima della grande crisi del 2008, Unicredit si è fuso con Capitalia, cioè ex banca di Roma, Intesa con San Paolo. Quindi sono rimasti tre poli.
Alberto Fossadri